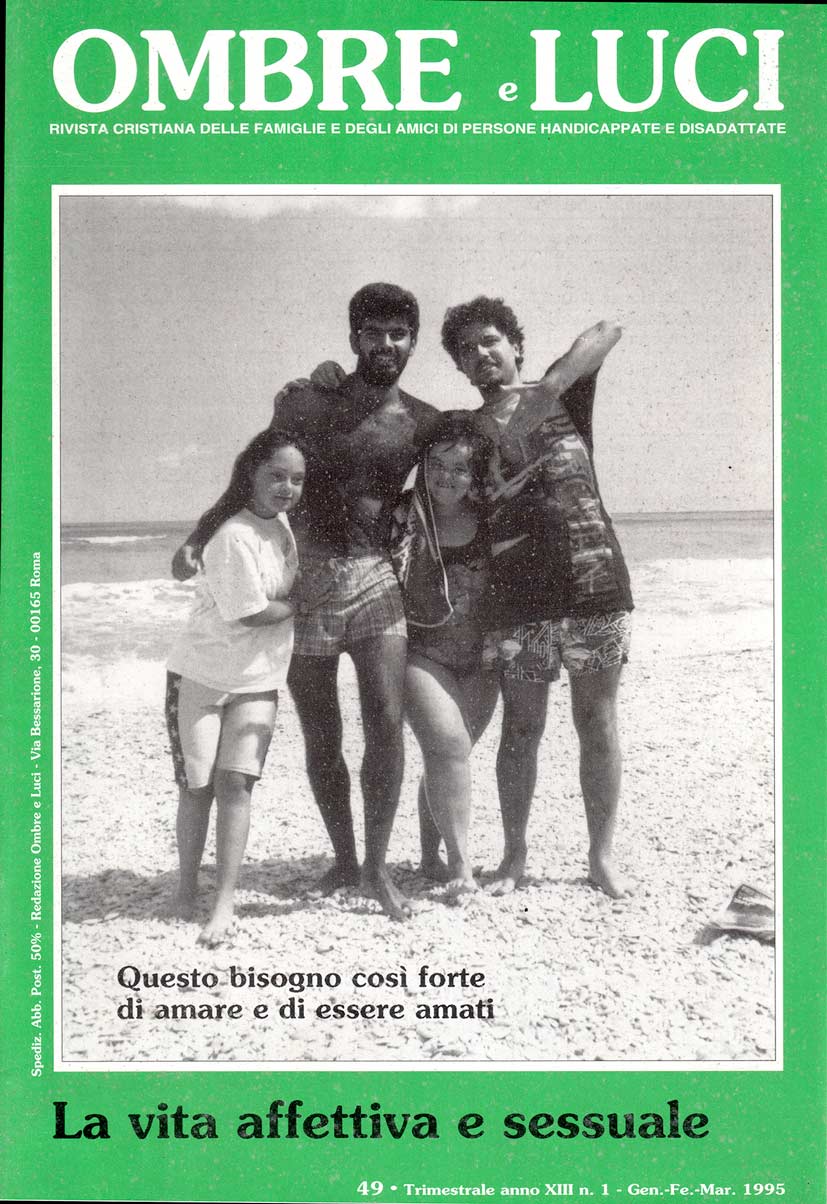Ho sempre pensato che l’essere medico significasse anche una condivisione con chi si rivolge a me, chiedendomi di capire la sua situazione psico-fisica.
D’altronde mi è ogni giorno più chiaro che nella nostra società, gran parte della patologia accusata, riguarda anche la sfera psichica, o comunque ha relazione con essa.
È quindi sempre più negativo un approccio alla malattia che trascuri il malato e non lo osservi nella propria integrità, cosa che purtroppo rischia di diventare abituale nella nostra cultura occidentale.
Tutto questo significa che nella mia professione non posso evitare di mettere in discussione anche la mia vita.
La mia convinzione è cresciuta nel riflettere su un’esperienza concreta da me vissuta. Ho avuto modo, infatti, di dover intervenire in un caso di un ragazzo down, che nella sua fase post-adolescenziale cominciava ad avvertire la mancanza di una ragazza, come vedeva nei suoi coetanei.
Era una sofferenza che sembrava pesante da sopportare e che metteva in crisi anche i familiari intorno.
Cosa proporre? Forse esperienze procurate che rischiavano poi di lasciarlo senza una risposta matura? Oppure dirgli che a lui non spettava un tale desiderio?
Ed in base a quale diritto negargli ogni speranza futura, anche se difficilmente immaginabile?
Confesso che rappresentava un bel problema e soprattutto mi chiedeva di immedesimarmi in una realtà spesso trascurata.
Così provai a parlargli partendo anche dalla mia esperienza personale, dicendo- gli anche le mie difficoltà e cercando piano piano di ricondurre questo problema nell’ambito di un più vasto orizzonte di crescita.
La ragazza così non diventava un terreno di conquista né qualcosa da possedere. Era una relazione da costruire con rispetto.
Sentivo che doveva convincersi che quella che lui provava come una impossibilità definitiva (questa infatti credo che fosse la sua inconscia paura) era una situazione che altri vivevano. E doveva abituarsi a convivere con certi limiti.
Cercavo di aiutarlo a valorizzare anche altri aspetti della sua vita: la capacità lavorativa, l’affidabilità nel portare a buon fine un compito a lui affidato, soprattutto il suo coinvolgimento nella vita delle altre persone intorno a lui.
Devo dire che questo dialogo fatto di condivisione la più semplice, ma anche la più completa, ha fatto maturare un rapporto di fiducia e di confidenza che ha aiutato entrambi.
Lentamente quel problema ha assunto una immagine meno drammatica, pur non essendo stato rimosso del tutto.
Forse il solo fatto di poterne parlare con semplicità, aveva rappresentato per lui una valvola di scarico.
E chiaro che questo non è un trattato di psicologia, ma solo l’osservazione che forse l’attenzione ed il coinvolgimento sono una strada percorribile e non priva di risultati.
– A. D. (medico), 1995
Questo articolo è tratto da
Ombre e Luci n.49, 1993
Sommario
Editoriale
Un tema difficile e delicato di M. Bertolini
Articoli
Domande e osservazioni dei genitori
L'educazione sessuale delle persone handicappate di V. Mariani
All’età in cui si cambia di M. Odile Réthoré
Come dirti, come spiegarti? di M. Peeters (medico)
Dialogo come cura di A. D. (medico)
Voglio sposarmi di J. Vanier
Il coraggio di parlare con loro di A. M.
Centro Artigianale di Bastia Umbra di N. Schulthes
Rubriche
Libri
Un libro risponde di N. Livi